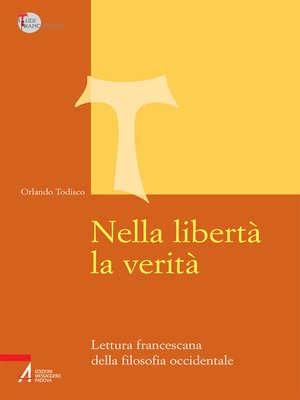
Sign up to save your library
With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.
Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.



Search for a digital library with this title
Title found at these libraries:
| Library Name | Distance |
|---|---|
| Loading... |
La "scuola francescana" come guida al pensiero filosofico occidentale. La sollecitazione a un nuovo stile di pensiero, secondo il quale la verità è la forma che la libertà in esercizio assume nel tempo.
INTRODUZIONE
«La concezione più profonda – scrive G. Simmel – è quella per cui esistono a priori soltanto diritti, per cui ogni individuo ha pretese – sia generalmente umane sia derivanti dalla sua situazione particolare – che soltanto come tali diventano doveri di altri soggetti». È il primato del diritto-a-essere, motivo sotterraneo della filosofia occidentale, diventato, con la filosofia moderna, programmatico e, con le filosofie del Novecento, l'orizzonte entro cui hanno preso volto proposte e movimenti di varia natura. Il dovere non è al primo posto, essendo piuttosto correlato del diritto. Detto in altro modo. Nel solco della razionalità greco-medievale, la modernità ha messo in luce l'anima giuridica di tale razionalità: l'essere è diritto-a-essere. L'età contemporanea da parte sua ha tradotto tale anima giuridica in diritti soggettivi, sociali, civili, individuali, in una sorta di sostanziale autoreferenzialità dell'io.
Alla luce di tale piega esistenziale, si tenta qui una rilettura della filosofia dell'Occidente, ispirata a siffatta razionalità, la cui stretta finale ha luogo con la filosofia moderna, quando l'esistere viene esplicitamente inteso come realizzazione di un diritto – conatus essendi di Spinoza o exigentia existendi di Leibniz o struggle-for-life di Darwin. L'età contemporanea ne ha tratto le conseguenze, dando vita a una stagione rivendicativa sia a livello sociale che propriamente politico. Per contrasto, si impone l'originalità della Scuola francescana, per la quale il punto di partenza non è il diritto-a-essere, ma il dono-di-essere, non l'altro in quanto contende o impone qualcosa, ma l'altro in quanto dà ciò che potrebbe non dare, sicché l'io è consapevole di essere perché colui che avrebbe potuto non volerlo lo ha voluto. Si è in un altro territorio, qualificato da un'ontologia che non si richiama all'essere in quanto essere, ma all'essere in quanto liberamente donato, dunque oltre l'alternativa diritto-dovere, entro la logica della libertà creativa nella gratuità.
A questo duplice registro di lettura delle tappe più significative della filosofia occidentale vorrei qui richiamarmi: uno descrittivo, nel senso che cerca di ricostruire la logica sostanzialmente rivendicativa dell'essere come diritto-a-essere, alla cui luce la filosofia occidentale si è sviluppata; l'altro prescrittivo, nel senso che allude alla logica sostanzialmente oblativa dell'essere, propria della filosofia francescana, per un auspicato nuovo modo di far filosofia. Da una parte la filosofia dell'essere come ciò che è in-sé ed è per sé, anche se non da sé, dall'altra la filosofia dell'essere come ciò che è in relazione o essere-per-l'altro; l'una è l'ontologia dell'autoaffermazione, l'altra l'ontologia della dedizione. A sostegno di questa sponda di confronto, paiono illuminanti non poche suggestioni teoretiche dei maestri francescani, da Alessandro d'Hales a Bonaventura, da Pietro di Giovanni Olivi a G. Duns Scoto, da Guglielmo d'Occam a Raimondo Lullo, la cui lezione concorde è costituita dal primato della libertà, del bene, dell'imprevedibile. Lezione da prendere sul serio se è vero che siamo al bivio del processo di razionalizzazione di tutti gli ambiti dell'essere, del sapere e dell'operare. Infatti, questo obiettivo primario della filosofia occidentale – procedere alla trasfigurazione razionale di tutto ciò che è, comprese le religioni – è contraddetto, nell'epoca contemporanea, dall'esplosione dell'irrazionalità, di cui sono prove...







