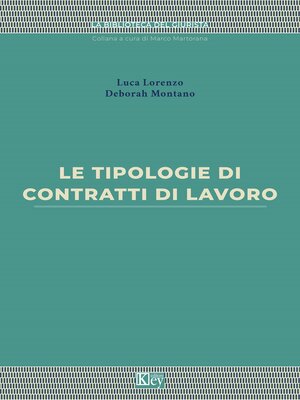
Sign up to save your library
With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.
Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.



Search for a digital library with this title
Title found at these libraries:
| Library Name | Distance |
|---|---|
| Loading... |
Attraverso uno studio comparativo gli autori hanno voluto evidenziare le differenze tra contratti di lavoro e contratti di diritto comune, ponendo l'accento sulla diversa natura e scopo.
I contratti di lavoro, come i CCNL, sono contratti normativi che disciplinano le condizioni di lavoro, stabilendo standard minimi e condizioni di lavoro per un gruppo di lavoratori in un determinato settore.
I contratti di diritto comune, invece, sono contratti individuali che regolano rapporti specifici tra due parti, come ad esempio la compravendita di un bene.
I contratti di lavoro (in linea di principio) hanno efficacia anche per i lavoratori non iscritti al sindacato che li ha stipulati, mentre i contratti di diritto comune hanno efficacia solo tra le parti che li hanno sottoscritti.
I contratti collettivi di lavoro stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo sono contratti regolati dalle norme del diritto privato in quanto le parti stipulanti sono semplici «associazioni di fatto», addirittura prive di personalità giuridica loro propria. Ne deriva che il contratto collettivo è vincolante nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentati dai rispettivi sindacati, rappresentanza che è implicita nell'adesione al sindacato. Sono rappresentati tutti gli iscritti al momento della stipulazione del contratto e anche (dal momento dell'iscrizione) coloro che si iscrivono successivamente in quanto l'ingresso in una formazione associativa implica l'assunzione dei diritti e degli obblighi anteriori all'acquisto della qualità di associato. I non iscritti al sindacato stipulante pertanto non hanno né gli obblighi, né i diritti contrattualmente stabiliti, almeno in prima approssimazione.
D'altronde, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il contratto collettivo deve essere applicato anche quando le parti abbiano in qualche modo «aderito» al contratto. L'adesione può essere esplicita, indicando nel contratto individuale o nella comunicazione di assunzione o nella lettera di assunzione che si applicherà un certo contratto collettivo, o anche implicita, attraverso la corresponsione ai dipendenti di una retribuzione corrispondente a quella prevista dal contratto collettivo, oppure attraverso l'osservanza di clausole contenute nel contratto collettivo; a maggior ragione si ritiene recepito il contratto collettivo se ne risulta la sua ripetuta applicazione.
Un contratto collettivo posteriore può contenere norme meno favorevoli al lavoratore rispetto a quelle del contratto collettivo precedente in base al principio della libera volontà e autonomia delle parti stipulanti che concludono il contratto dopo avere valutato, autonomamente e liberamente, la situazione esistente al momento della stipulazione e quella prevedibile nel periodo di validità del contratto.
Si può considerare per giurisprudenza consolidata anche la possibilità che un contratto collettivo di grado inferiore (per esempio un contratto territoriale o anche aziendale, rispetto al contratto collettivo nazionale) stipulato posteriormente contenga clausole meno favorevoli al lavoratore rispetto al precedente (e tuttora vigente) contratto collettivo di grado superiore e questo particolarmente se tale peggioramento delle condizioni è giustificato dall'obiettivo di raggiungere altri risultati di preminente interesse dei lavoratori (per esempio evitare la cessazione dell'attività, incrementare l'occupazione, ecc.).
Fatto salvo quanto subito diremo sulla attuale disciplina degli assetti contrattuali, non è stato ritenuto applicabile il principio ora richiamato nel caso della contrattazione articolata, quando cioè il contratto collettivo di validità più estesa (nazionale o...







